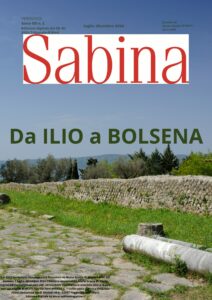di Lorena Paris
“Mi dava pena saperti lì sola”
di Flaminia Cruciani
“Mi dava pena saperti lì sola
seduta in fondo all’Universo,
sembravi un nome vergine ingrandito da ore malridotte.
Ho partorito l’umanità nei boschi dell’indifferenza
quando rovistavo nella vertigine
del cielo come in un cassonetto.
Poi ci sorprese l’amore
e sotto quel cielo guasto
noi tacevamo nella stessa lingua.”
Questa, una delle bellissime poesie di Flaminia Cruciani, archeologa e poetessa romana. Una voce molto apprezzata, nel panorama letterario nazionale e internazionale. Versi che declinano con forza il legame tra cielo e terra, un’ unione concreta tra mistero svelato e conoscenza nascosta. Ossimoro vivido che muove le parole della poetessa: nel suo racconto, il desiderio di capire, di conoscere, di riportare ciò che era esistenza, alla luce. La ricerca del sentimento vitale e ancestrale, delle origini, del tempo che precede e che segue. Una storia poetica infinita, di vite e legami paralleli che abbattono il ciclo dei millenni. Il punto culminante dei versi è proprio nel finale di poesia, dove il silenzio della comunicazione fisica e spirituale – tra passato e presente – parla la stessa lingua.
Ritrovo, infine, nel “messaggio” della poesia un concetto molto caro alla Cruciani, ovvero che:
“Se il lavoro del poeta è scuotere il cielo aspettando che qualche frammento cada, il lavoro dell’archeologo è scuotere la terra, senza imbarazzo del cosmo, aspettando che qualche frammento di cielo appaia”.
Ecco uno stralcio del suo pensiero sulla relazione tra archeologia e poesia:
” Dopo averci pensato a lungo, mentre facevo l’archeologa e più tardi a riposo, quando quelle emozioni si erano già sedimentate, è apparso sempre più evidente al mio sguardo di poeta che l’archeologia avesse una sua poetica e che fosse così affascinante che bisognasse raccontarla. Era chiaro per me che questa poetica dell’archeologia fosse proprio l’immortalità. Siamo abituati a pensare che l’immortalità sia una linea che non finisce, mentre io da archeologa la sento piuttosto come un istante eterno: quello della scoperta, l’archeologia forse è il momento supremo, il kairos, dell’immortalità(…) Sia la poesia, sia l’archeologia svelano, rivelano partendo proprio da frammenti e si muovono su un tessuto comune quello della memoria, del tirare fuori dal profondo per riportare alla luce. Il poeta nella sua rêverie, ricerca le sostanze poetiche nell’infinita profondità dell’intimo sentire (la sostanza poetica è lì nel luogo del riposo, che diviene espressione viva e pulsante di questo mondo sotterraneo e del suo enigma), l’archeologo in quella finita della terra e della storia. I reperti, i gesti, le abitudini, le azioni compiute riposano nella terra e rivedono la luce grazie all’archeologo, che possiamo immaginare come un poeta delle nostre tracce. La ricostruzione delle cose antiche è una “riflessione”, una visione non diretta, ma riflessa appunto, del passato come in uno specchio, simile a quello di Dioniso dei Misteri. Dove le immagini dell’antico gli appaiono e sono estremamente fugaci. Si tratta di una sorta d’iniziazione ai Misteri dopo la discesa nel labirinto infero, nelle profondità della terra. Anche la poesia è un mistero: chiedere che cosa sia la poesia è come domandare se la tela di Penelope fosse tessuta al dritto o al rovescio. C’è quindi un rapporto d’imprevedibilità che accomuna l’archeologia con il fare poesia. È questo rapporto con il segreto, con il nascosto, con il sepolto che come tale è sconosciuto (…).